Rassegnazione e progetto nei personaggi di Cechov
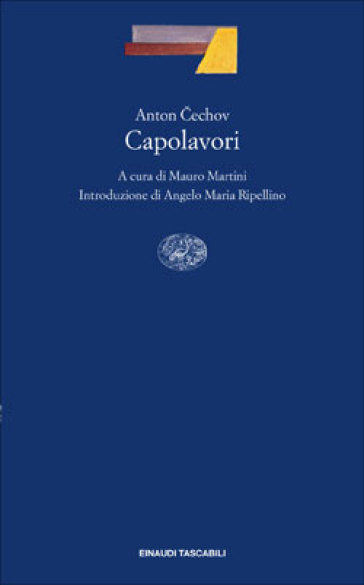 C’è una dimensione, tanto letteraria quanto reale che, per quanto ripetuta a lungo, non sembra proprio passare di moda: la noia del quotidiano e l’assurdità del suo ripetersi. Dopo due secoli di “letteratura della noia”, da Leopardi, passando per Sartre, e arrivando agli infiniti imitatori di oggi, dovremmo averne abbastanza. In fondo, in questa disposizione d’animo tipica della modernità risiede tutta la verità delle nostre dormienti province, delle nostre città caotiche e inconcludenti; una realtà solo superficialmente scalfita dalla rivoluzione dell’iper-velocità delle comunicazioni. Leggete i drammi di Cechov, e vi accorgerete come il clima dei suoi dialoghi, ambientati in una dormiente Russia rurale della fine del XIX secolo, poco si discosta da molti dei nostri atteggiamenti.
C’è una dimensione, tanto letteraria quanto reale che, per quanto ripetuta a lungo, non sembra proprio passare di moda: la noia del quotidiano e l’assurdità del suo ripetersi. Dopo due secoli di “letteratura della noia”, da Leopardi, passando per Sartre, e arrivando agli infiniti imitatori di oggi, dovremmo averne abbastanza. In fondo, in questa disposizione d’animo tipica della modernità risiede tutta la verità delle nostre dormienti province, delle nostre città caotiche e inconcludenti; una realtà solo superficialmente scalfita dalla rivoluzione dell’iper-velocità delle comunicazioni. Leggete i drammi di Cechov, e vi accorgerete come il clima dei suoi dialoghi, ambientati in una dormiente Russia rurale della fine del XIX secolo, poco si discosta da molti dei nostri atteggiamenti.
Oggi siamo, in molti casi, ancora potenziali personaggi cechoviani. Prima di tutto perché – e pare sia condizione comune a molti – una volontà paralitica avvolge molti aspetti del nostro vivere. Imputiamo la nostra incapacità di agire (realizzare progetti grandiosi o semplicemente eseguire in piena coscienza compiti di più ordinaria quotidianità) alla monotonia molesta e demotivante, ad un caso che ci ha impedito di essere quello che potevamo essere. Così Sorin, in Il Gabbiano:
SORIN In giovinezza una volta volevo diventare un uomo di lettere – e non lo sono diventato, volevo essere un parlatore – e ho sempre parlato in maniera nauseante […].
e più avanti
SORIN […] Volevo sposarmi, e non mi sono sposato; volevo vivere sempre in città, e finisco la mia vita in campagna.
Così i personaggi di Cechov – questi spettri per nulla drammatici, ma solo annoiati – si creano un alibi di fronte alla propria paralisi: il caso avverso e lo squallore del quotidiano. Certo, non si arrendono proprio del tutto e qualche volta manifestano desideri e visioni di un futuro che potrebbe redimerli e persino realizzarli. Le tre sorelle del dramma omonimo sono tormentate da un’idea fissa: tornare, dopo tanti anni, nella più vitale Mosca e abbandonare la desertica provincia russa, piena di freddo e di zanzare. Ma Mosca, come molti luoghi letterari, rappresenta solo un altrove temporale e spaziale per un illusorio impulso di rinnovamento.
Ma Anton Cechov, d’altra parte, aveva indicato una via d’uscita da questa immobilità: e se questo non era così chiaro nel Cechov-letterato, era più visibile in Cechov-persona (le sue lettere, la testimonianza di amici letterati, lo suggeriscono). Irina, in Tre sorelle, nel giorno del suo onomastico, giorno funestato anche dal ricordo della morte del padre avvenuta esattamente un anno prima, ritrova in quella mattina un’insolita luminosità:
IRINA Quando stamattina mi sono svegliata, mi sono alzata e mi sono lavata, di colpo ci ho visto chiaro. Ho visto il mondo com’è, come bisogna vivere. […] il dovere dell’uomo consiste nel faticare, nel lavorare duro, con il sudore della propria fronte, perché questo è il senso della sua vita, la sua felicità, il suo appagamento.
Qui lo scrittore russo esplicita la propria visione nel dialogo del personaggio Irina. Cechov pose in secondo piano la pratica medica per dedicarsi alla letteratura, e seppure malato e costretto a vivere dove non voleva per i problemi di salute che lo tormentavano, si forgiò una ferrea volontà, un’attitudine al lavoro che si concretizzava in una pratica e una progettualità costante della propria opera. Non era un disperato poeta maledetto, ma una persona concreta, ordinata, pacata e gentile, distante da ogni teatralità tipica della figura dell’artista che di lì a poco sarebbe divenuta una moda.
Lavoro, progetto, costanza. Questa è la via d’uscita che ipotizzava Cechov dalla noia dell’assurdo, e questo è quello che in fin dei conti egli stesso mise in pratica concretamente nella sua vita (realizzando, tra l’altro, un’insolita convergenza tra letteratura ed esistenza). Non tutti, probabilmente, sono in grado di reagire secondo la direzione appena indicata. Ancora in Tre sorelle, poco più avanti, in risposta a Irina, Cebutykin, un apatico ufficiale medico, risponde:
CEBUTYKIN Io in vita mia, a dirla tutta, non ho mai lavorato. Appena finita l’università mi sono limitato a girarmi i pollici, non ho nemmeno letto un libretto, ma solo giornali […].
Ma non pensiamo ad uno scontro dualistico di visioni ben definite. Anche la dichiarazione di intenti di Irina è per certi versi illusoria. Ma un conto è rassegnarsi al sonno della banalità dell’esistenza, un conto cercare di svegliarsi da questo sonno e qualche volta riuscire a farlo.
Il solo tentativo, il solo impegno nel portare avanti l’attitudine al fare (concetto inteso in senso molto ampio), rende l’uomo più felice e cosciente del fatto che – dopo tutto – non sta sprecando invano i suoi giorni.