Di libri, di letteratura, di contaminazioni. In particolare mi interessa la visione comparativa tra Oriente e Occidente. L’Asia Orientale, – tra Giappone, Cina e Corea, – è lo spazio immaginativo in cui mi immergo da tempo. Da qualche anno trascorro l’autunno in Asia per dedicarmi al perfezionamento linguistico, alla scrittura di opere narrative e a ricerche indipendenti nell’ambito degli Studi Asiatici. (Clicca qui per approfondire)
Scrivo, ma spesso preferisco i libri degli altri ai miei. Mi interessa la letteratura perché, tutto sommato, amo gli esseri umani. E la letteratura, intreccio di storie, idee ed emozioni, è uno specchio profondo, sublime e inquietante, per capire tutto ciò che è umano.
Se vi interessano i temi trattati, potete seguire la pagina Facebook cliccando qui.
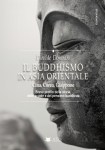 Dalle origini indiane allo Zen: percorsi storici e scuole del Buddhismo in Asia Orientale. Questo agile volume ripercorre la storia del Buddhismo in Cina, Corea e Giappone da una prospettiva integrata, considerando l’Asia Orientale come uno spazio culturale unitario, plasmato dall’eredità della civiltà cinese e al tempo stesso segnato dall’originalità delle singole tradizioni nazionali.
Dalle origini indiane allo Zen: percorsi storici e scuole del Buddhismo in Asia Orientale. Questo agile volume ripercorre la storia del Buddhismo in Cina, Corea e Giappone da una prospettiva integrata, considerando l’Asia Orientale come uno spazio culturale unitario, plasmato dall’eredità della civiltà cinese e al tempo stesso segnato dall’originalità delle singole tradizioni nazionali. Conoscere la storia di una lingua che si studia forse non è una tappa obbligata, ma per chi desidera penetrare in profondità quella lingua e la cultura che essa esprime, è certamente un viaggio affascinante che fornisce una prospettiva nuova anche alla nostra conoscenza della lingua concreta, quella della quotidianità. Difficile condensare in poche parole un invito alla lettura per il manuale di P. Calvetti e G. Pappalardo, La storia della lingua giapponese. Dalle origini alla lingua moderna, perché è un’opera che richiede un’attenzione particolare. Non a caso, si tratta di un testo universitario, sebbene si presenti come un compendio che descrive lo stato attuale delle conoscenze sulla storia della lingua giapponese.
Conoscere la storia di una lingua che si studia forse non è una tappa obbligata, ma per chi desidera penetrare in profondità quella lingua e la cultura che essa esprime, è certamente un viaggio affascinante che fornisce una prospettiva nuova anche alla nostra conoscenza della lingua concreta, quella della quotidianità. Difficile condensare in poche parole un invito alla lettura per il manuale di P. Calvetti e G. Pappalardo, La storia della lingua giapponese. Dalle origini alla lingua moderna, perché è un’opera che richiede un’attenzione particolare. Non a caso, si tratta di un testo universitario, sebbene si presenti come un compendio che descrive lo stato attuale delle conoscenze sulla storia della lingua giapponese.  In un’epoca in cui la ricerca della felicità è ridotta a slogan, manuali rapidi e illusioni consumistiche, questo libro invita a fermarsi e a guardare in faccia la realtà. “Il fiore e la rugiada. Sul dovere di essere felici” propone un cammino tra filosofia occidentale, scienza e pensiero buddhista, alla ricerca di una gioia possibile che non fugge dal dolore e che nasce dalla consapevolezza del presente.
In un’epoca in cui la ricerca della felicità è ridotta a slogan, manuali rapidi e illusioni consumistiche, questo libro invita a fermarsi e a guardare in faccia la realtà. “Il fiore e la rugiada. Sul dovere di essere felici” propone un cammino tra filosofia occidentale, scienza e pensiero buddhista, alla ricerca di una gioia possibile che non fugge dal dolore e che nasce dalla consapevolezza del presente. 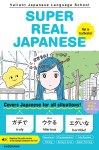 Si tratta di un volumetto di circa 200 pagine realizzato nella tipica grafica dell’editoria didattica giapponese (kawaii style). Ho acquistato Super Real Japanese a Ikebukuro un paio di anni fa; ricordo spesso con precisione le occasioni in cui mi procuro i libri di cui parlo, perché trovo suggestivo associare ogni volume a una storia.
Si tratta di un volumetto di circa 200 pagine realizzato nella tipica grafica dell’editoria didattica giapponese (kawaii style). Ho acquistato Super Real Japanese a Ikebukuro un paio di anni fa; ricordo spesso con precisione le occasioni in cui mi procuro i libri di cui parlo, perché trovo suggestivo associare ogni volume a una storia. In cerca della parola giusta. Questa storia risale a qualche anno fa. Me ne sono però ricordato riguardando alcune delle mie “schede del lessico”. Da decenni, ormai (letteralmente), sono solito raccogliere in “schede”, fisiche, scritte a mano, parole ed espressioni nuove che imparo nelle mie chiacchierate nelle lingue straniere, liste che poi integro in modo tematico. Una volta dovevamo aver parlato di templi buddhisti o qualcosa del genere. Mi ero messo a cercare la parola “lanterna” perché volevo esprimere la mia idea su un oggetto che avevo in mente. Certo, non avevo bisogno di conferma sulla complessità e la profondità delle lingue, ma ogni volta che vi inciampo, ne rimango affascinato. Ecco, quindi, che cercavo solo di capire come “dire” una parola, e sono invece rimasto avvolto da un vortice intrecciato di tempo e tradizioni.
In cerca della parola giusta. Questa storia risale a qualche anno fa. Me ne sono però ricordato riguardando alcune delle mie “schede del lessico”. Da decenni, ormai (letteralmente), sono solito raccogliere in “schede”, fisiche, scritte a mano, parole ed espressioni nuove che imparo nelle mie chiacchierate nelle lingue straniere, liste che poi integro in modo tematico. Una volta dovevamo aver parlato di templi buddhisti o qualcosa del genere. Mi ero messo a cercare la parola “lanterna” perché volevo esprimere la mia idea su un oggetto che avevo in mente. Certo, non avevo bisogno di conferma sulla complessità e la profondità delle lingue, ma ogni volta che vi inciampo, ne rimango affascinato. Ecco, quindi, che cercavo solo di capire come “dire” una parola, e sono invece rimasto avvolto da un vortice intrecciato di tempo e tradizioni.  Proseguiamo con la nostra rubrica “Libri per studiare”, dedicata ai testi fondamentali per comprendere le lingue, la storia e le culture dell’Asia Orientale. Oggi ci spostiamo sul piano filosofico e storiografico con un’opera che definire “classica” è riduttivo: “Storia del pensiero cinese” di Anne Cheng. Pubblicato in Italia da Einaudi nella prestigiosa collana “Piccola Biblioteca”, questo saggio rimane uno strumento imprescindibile non solo per i sinologi, ma per chiunque voglia decifrare le radici intellettuali dell’intera Asia Orientale. L’autrice, Anne Cheng, è una figura di spicco nel panorama accademico internazionale. Titolare della cattedra di “Storia intellettuale della Cina” al Collège de France, rappresenta perfettamente il ponte tra Oriente e Occidente. Nata in Francia da genitori cinesi, la sua doppia appartenenza culturale le conferisce una sensibilità rara nel tradurre concetti complessi senza tradirne l’essenza originale. Ricordo persino di aver scorto la traduzione giapponese del suo testo in una libreria di Tokyo, segno del prestigio globale di cui gode quest’opera.
Proseguiamo con la nostra rubrica “Libri per studiare”, dedicata ai testi fondamentali per comprendere le lingue, la storia e le culture dell’Asia Orientale. Oggi ci spostiamo sul piano filosofico e storiografico con un’opera che definire “classica” è riduttivo: “Storia del pensiero cinese” di Anne Cheng. Pubblicato in Italia da Einaudi nella prestigiosa collana “Piccola Biblioteca”, questo saggio rimane uno strumento imprescindibile non solo per i sinologi, ma per chiunque voglia decifrare le radici intellettuali dell’intera Asia Orientale. L’autrice, Anne Cheng, è una figura di spicco nel panorama accademico internazionale. Titolare della cattedra di “Storia intellettuale della Cina” al Collège de France, rappresenta perfettamente il ponte tra Oriente e Occidente. Nata in Francia da genitori cinesi, la sua doppia appartenenza culturale le conferisce una sensibilità rara nel tradurre concetti complessi senza tradirne l’essenza originale. Ricordo persino di aver scorto la traduzione giapponese del suo testo in una libreria di Tokyo, segno del prestigio globale di cui gode quest’opera.  All’inizio non lo sapevo che stavo ascoltando un “fantasma” del web. La sua voce era lì, in sottofondo, in una playlist nata quasi spontaneamente. Dopo settimane in cui quella melodia tornava a cercarmi con regolarità, ho deciso di dare un’occhiata al canale YouTube. È stato allora che ho scoperto il fenomeno dei Virtual Singers nella musica pop giapponese. La cantante che stavo ascoltando, Asu (
All’inizio non lo sapevo che stavo ascoltando un “fantasma” del web. La sua voce era lì, in sottofondo, in una playlist nata quasi spontaneamente. Dopo settimane in cui quella melodia tornava a cercarmi con regolarità, ho deciso di dare un’occhiata al canale YouTube. È stato allora che ho scoperto il fenomeno dei Virtual Singers nella musica pop giapponese. La cantante che stavo ascoltando, Asu ( Inauguriamo questa nuova rubrica, molto semplicemente intitolata “Libri per studiare”, dedicata a consigli pratici per l’apprendimento delle lingue, della cultura e della storia dell’Asia orientale. Il primo volume di cui voglio parlare è Odekake Nihongo Kaiwa della YouTuber Akane (titolo completo originale,
Inauguriamo questa nuova rubrica, molto semplicemente intitolata “Libri per studiare”, dedicata a consigli pratici per l’apprendimento delle lingue, della cultura e della storia dell’Asia orientale. Il primo volume di cui voglio parlare è Odekake Nihongo Kaiwa della YouTuber Akane (titolo completo originale,  Introduzione. Questo articolo esplora come famiglie linguistiche distinte, rappresentate dall’italiano (come esempio di lingua indoeuropea) e dal giapponese, organizzino concetti pragmatici universali quali l’espressione del consiglio, del desiderio e della necessità attraverso architetture grammaticali divergenti. Partendo da un’analisi della costruzione giapponese “-ta hō ga ii”, equivalente funzionale di espressioni come “è meglio…”, risulta chiaro come la realizzazione di significati affini avvenga non per stretta corrispondenza lessicale, ma attraverso principi sintattico-pragmatici differenti. L’analisi rivela una dicotomia tra un approccio dichiarativo ed esplicito, tipico delle lingue europee, e un approccio relazionale ed implicito, caratteristico del giapponese, suggerendo che la grammatica operi come un filtro cognitivo attivo nell’organizzazione dell’esperienza.
Introduzione. Questo articolo esplora come famiglie linguistiche distinte, rappresentate dall’italiano (come esempio di lingua indoeuropea) e dal giapponese, organizzino concetti pragmatici universali quali l’espressione del consiglio, del desiderio e della necessità attraverso architetture grammaticali divergenti. Partendo da un’analisi della costruzione giapponese “-ta hō ga ii”, equivalente funzionale di espressioni come “è meglio…”, risulta chiaro come la realizzazione di significati affini avvenga non per stretta corrispondenza lessicale, ma attraverso principi sintattico-pragmatici differenti. L’analisi rivela una dicotomia tra un approccio dichiarativo ed esplicito, tipico delle lingue europee, e un approccio relazionale ed implicito, caratteristico del giapponese, suggerendo che la grammatica operi come un filtro cognitivo attivo nell’organizzazione dell’esperienza.  La politica tende sempre a polarizzare e a generare tensioni. Per uno spazio come questo, e per la pagina social ad esso collegata che tratta temi culturali sull’Asia Orientale, non è mai ideale affrontarla in modo diretto. Tuttavia l’attualità delle tensioni tra Cina e Giappone mi spinge a condividere qualche riflessione. Mi trovo infatti nella particolare condizione di nutrire una profonda passione per entrambe le culture. I rapporti storici e culturali tra Cina e Giappone sono forse il tema che più mi affascina. Mi capita di “litigare” bonariamente con amici giapponesi lodando la Cina, così come di ricevere commenti poco lusinghieri quando con amici cinesi esprimo apprezzamento per il Giappone.
La politica tende sempre a polarizzare e a generare tensioni. Per uno spazio come questo, e per la pagina social ad esso collegata che tratta temi culturali sull’Asia Orientale, non è mai ideale affrontarla in modo diretto. Tuttavia l’attualità delle tensioni tra Cina e Giappone mi spinge a condividere qualche riflessione. Mi trovo infatti nella particolare condizione di nutrire una profonda passione per entrambe le culture. I rapporti storici e culturali tra Cina e Giappone sono forse il tema che più mi affascina. Mi capita di “litigare” bonariamente con amici giapponesi lodando la Cina, così come di ricevere commenti poco lusinghieri quando con amici cinesi esprimo apprezzamento per il Giappone. 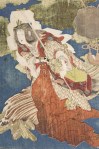 La famosa diade concettuale di Apollineo e Dionisiaco esposta dal filosofo Friedrich Nietzsche ne La nascita della tragedia, ha avuto nel corso del Novecento e oltre una gran fortuna nel pensiero filosofico, imponendosi come una lente potente per analizzare le tensioni alla base della cultura occidentale e arrivando a influenzare anche letteratura e arte. Il concetto di Apollineo, che trae il suo nome dalla nota divinità greca, rappresenta il principio della razionalità, dell’ordine, della distinzione dei confini individuali e del sogno controllato. L’Apollineo è contrapposto da Nietzsche al Dionisiaco, in onore all’omonimo dio del vino e dell’estasi, principio che incarna al contrario la forza primordiale dell’ebbrezza, della dissoluzione dell’io nell’indistinto, della spontaneità naturale e della frenesia orgiastica.
La famosa diade concettuale di Apollineo e Dionisiaco esposta dal filosofo Friedrich Nietzsche ne La nascita della tragedia, ha avuto nel corso del Novecento e oltre una gran fortuna nel pensiero filosofico, imponendosi come una lente potente per analizzare le tensioni alla base della cultura occidentale e arrivando a influenzare anche letteratura e arte. Il concetto di Apollineo, che trae il suo nome dalla nota divinità greca, rappresenta il principio della razionalità, dell’ordine, della distinzione dei confini individuali e del sogno controllato. L’Apollineo è contrapposto da Nietzsche al Dionisiaco, in onore all’omonimo dio del vino e dell’estasi, principio che incarna al contrario la forza primordiale dell’ebbrezza, della dissoluzione dell’io nell’indistinto, della spontaneità naturale e della frenesia orgiastica.  L’interesse dell’Occidente per il Buddhismo è un fenomeno complesso e stratificato, il cui sviluppo abbraccia tre secoli di storia. In origine, nell’Ottocento, la dottrina del Buddha aveva attirato l’interesse di un’élite di intellettuali, alimentato dal fenomeno dell’Orientalismo, l’imitazione o rappresentazione di culture asiatiche fiorita dopo le esplorazioni coloniali, e dall’applicazione dei nuovi metodi filologici allo studio dei testi orientali. Questo approccio iniziale fu quindi prevalentemente accademico, artistico e filologico, non rispondendo ad esigenze di tipo spirituale.
L’interesse dell’Occidente per il Buddhismo è un fenomeno complesso e stratificato, il cui sviluppo abbraccia tre secoli di storia. In origine, nell’Ottocento, la dottrina del Buddha aveva attirato l’interesse di un’élite di intellettuali, alimentato dal fenomeno dell’Orientalismo, l’imitazione o rappresentazione di culture asiatiche fiorita dopo le esplorazioni coloniali, e dall’applicazione dei nuovi metodi filologici allo studio dei testi orientali. Questo approccio iniziale fu quindi prevalentemente accademico, artistico e filologico, non rispondendo ad esigenze di tipo spirituale.  A view of the city. How could a collectivist society — one in which the group is more important than the individual, and where relationships and hierarchy are central — become a fragmented society of people who rush about, busy and often alone, like isolated atoms spinning in empty space? Tokyo is not Japan; it is an exception — as all large metropolises are. The “average” life may well be found in smaller towns and provincial cities. Yet Tokyo, as an exception, contains both what is traditional and characteristic of the local culture and what departs from it. After spending most autumns here for three years, I have slowly and with difficulty begun to form a deeper sense of the city — not so much through its outward manifestations or its urban layout, but through what I might call Tokyo’s “intimate emotional life.”
A view of the city. How could a collectivist society — one in which the group is more important than the individual, and where relationships and hierarchy are central — become a fragmented society of people who rush about, busy and often alone, like isolated atoms spinning in empty space? Tokyo is not Japan; it is an exception — as all large metropolises are. The “average” life may well be found in smaller towns and provincial cities. Yet Tokyo, as an exception, contains both what is traditional and characteristic of the local culture and what departs from it. After spending most autumns here for three years, I have slowly and with difficulty begun to form a deeper sense of the city — not so much through its outward manifestations or its urban layout, but through what I might call Tokyo’s “intimate emotional life.” 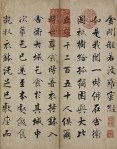 In debates about Buddhism—especially when discussing practice and the spiritual value of the Buddha’s message—it is common to encounter claims that the doctrine’s historical development has altered its “original” message. Such judgments typically imply two things: on the one hand, they presuppose the existence of an immutable origin against which change can be measured; on the other, they often carry a value judgment that denounces the present as corrupted or decayed compared with an alleged primordial purity. This is an ancient religious topos that connects an original message to the degeneration of later times. This reading is problematic and, from both historical and philosophical standpoints, should be approached with caution.
In debates about Buddhism—especially when discussing practice and the spiritual value of the Buddha’s message—it is common to encounter claims that the doctrine’s historical development has altered its “original” message. Such judgments typically imply two things: on the one hand, they presuppose the existence of an immutable origin against which change can be measured; on the other, they often carry a value judgment that denounces the present as corrupted or decayed compared with an alleged primordial purity. This is an ancient religious topos that connects an original message to the degeneration of later times. This reading is problematic and, from both historical and philosophical standpoints, should be approached with caution.  Non penso di essere il solo ad accostare spesso la letteratura giapponese al concetto di “minimalismo”. Si tratta di un concetto vago e allusivo, a sua volta difficile da definire. La lettura di molte opere note di questa letteratura è in grado proprio di suscitare questa sensazione: nella povertà relativa di eventi, si intravede un mondo poetico di allusioni che, con pochi tratti, disegna trame più complesse in controluce. In particolare, le opere di era Meiji, Taishō e della prima parte dell’era Shōwa, vale a dire dalla seconda metà dell’Ottocento fino agli anni Trenta del Novecento, circa. L’oca selvatica
Non penso di essere il solo ad accostare spesso la letteratura giapponese al concetto di “minimalismo”. Si tratta di un concetto vago e allusivo, a sua volta difficile da definire. La lettura di molte opere note di questa letteratura è in grado proprio di suscitare questa sensazione: nella povertà relativa di eventi, si intravede un mondo poetico di allusioni che, con pochi tratti, disegna trame più complesse in controluce. In particolare, le opere di era Meiji, Taishō e della prima parte dell’era Shōwa, vale a dire dalla seconda metà dell’Ottocento fino agli anni Trenta del Novecento, circa. L’oca selvatica Gli esami di certificazione e gli esami universitari servono davvero a qualcosa? È una domanda che può sembrare retorica, ma nasconde varie ambiguità. La competenza linguistica si mostra soprattutto attraverso l’efficacia comunicativa con i parlanti nativi; tuttavia la correttezza grammaticale e la capacità di articolare pensieri complessi dipendono anch’esse da una conoscenza strutturata della lingua. Questa affermazione è condivisibile, ma richiede precisazioni: conviene riflettere sui limiti dei metodi impiegati per «verificare» la conoscenza linguistica.
Gli esami di certificazione e gli esami universitari servono davvero a qualcosa? È una domanda che può sembrare retorica, ma nasconde varie ambiguità. La competenza linguistica si mostra soprattutto attraverso l’efficacia comunicativa con i parlanti nativi; tuttavia la correttezza grammaticale e la capacità di articolare pensieri complessi dipendono anch’esse da una conoscenza strutturata della lingua. Questa affermazione è condivisibile, ma richiede precisazioni: conviene riflettere sui limiti dei metodi impiegati per «verificare» la conoscenza linguistica.  Se studiate la lingua giapponese e ambite a comunicare fluentemente, armatevi di pazienza e dedicate qualche minuto a questo articolo. Chiunque ami imparare lingue straniere sa che l’ascolto prolungato e quotidiano – dopo aver acquisito un vocabolario di base e una conoscenza generale delle strutture grammaticali – conduce a progressi sorprendenti se portato avanti con costanza. Lo comprensione teorica della struttura di una lingua è fondamentale, ma va affiancata il prima possibile all’uso pratico: parlate e ascoltate il più possibile. In altre parole, divertitevi, esplorate, innamoratevi e vivete la lingua che desiderate apprendere. La lingua straniera che studiate deve diventare parte di voi, è l’unico modo per impararla veramente.
Se studiate la lingua giapponese e ambite a comunicare fluentemente, armatevi di pazienza e dedicate qualche minuto a questo articolo. Chiunque ami imparare lingue straniere sa che l’ascolto prolungato e quotidiano – dopo aver acquisito un vocabolario di base e una conoscenza generale delle strutture grammaticali – conduce a progressi sorprendenti se portato avanti con costanza. Lo comprensione teorica della struttura di una lingua è fondamentale, ma va affiancata il prima possibile all’uso pratico: parlate e ascoltate il più possibile. In altre parole, divertitevi, esplorate, innamoratevi e vivete la lingua che desiderate apprendere. La lingua straniera che studiate deve diventare parte di voi, è l’unico modo per impararla veramente.  Michele Prisco era considerato un autore importante della letteratura italiana del dopoguerra. La sua lunghissima carriera letteraria, iniziata nell’immediato dopoguerra, si è protratta fino alle soglie del nuovo millennio, con esiti altalenanti per quanto riguarda la fortuna editoriale dei suoi libri. È stata invece la cosiddetta “fortuna postuma” a non rendere giustizia a questo autore: oggi sono davvero poche le sue opere ancora reperibili sul mercato, riedite di recente. Qualche tempo fa, cercando tra gli autori del secondo “Novecento italiano dimenticato”, avevo inserito Prisco tra le mie letture. Per vie fortuite (libri ereditati), alcuni anni fa sono entrato in possesso di alcuni suoi romanzi e il primo che ho deciso di leggere non è stato il suo più famoso e, a quanto pare, il più importante (Una spirale di nebbia, Premio Strega 1966), bensì un’opera relativamente tarda: Le parole del silenzio.
Michele Prisco era considerato un autore importante della letteratura italiana del dopoguerra. La sua lunghissima carriera letteraria, iniziata nell’immediato dopoguerra, si è protratta fino alle soglie del nuovo millennio, con esiti altalenanti per quanto riguarda la fortuna editoriale dei suoi libri. È stata invece la cosiddetta “fortuna postuma” a non rendere giustizia a questo autore: oggi sono davvero poche le sue opere ancora reperibili sul mercato, riedite di recente. Qualche tempo fa, cercando tra gli autori del secondo “Novecento italiano dimenticato”, avevo inserito Prisco tra le mie letture. Per vie fortuite (libri ereditati), alcuni anni fa sono entrato in possesso di alcuni suoi romanzi e il primo che ho deciso di leggere non è stato il suo più famoso e, a quanto pare, il più importante (Una spirale di nebbia, Premio Strega 1966), bensì un’opera relativamente tarda: Le parole del silenzio.  Negli anni è stata annunciata la fine di Facebook innumerevoli volte. Eppure il vecchio social network – che ormai ha compiuto vent’anni – continua a tornare a galla, macinando utili. Certo, è evidente che la fascia più giovane abbia abbandonato da tempo la piattaforma di Zuckerberg: la battuta “Facebook è quello blu”, usata dai ragazzi per liquidare i commenti “boomer”, è diventata un’icona generazionale. Al di là delle dispute tra vecchie e nuove generazioni, Facebook conserva una peculiarità cruciale per chi si dedica alla scrittura o a certi tipi di “creazione di contenuti” (sì, suona strano dirlo in italiano, lo so): qui la parola scritta resiste, affiancando ancora immagini e video.
Negli anni è stata annunciata la fine di Facebook innumerevoli volte. Eppure il vecchio social network – che ormai ha compiuto vent’anni – continua a tornare a galla, macinando utili. Certo, è evidente che la fascia più giovane abbia abbandonato da tempo la piattaforma di Zuckerberg: la battuta “Facebook è quello blu”, usata dai ragazzi per liquidare i commenti “boomer”, è diventata un’icona generazionale. Al di là delle dispute tra vecchie e nuove generazioni, Facebook conserva una peculiarità cruciale per chi si dedica alla scrittura o a certi tipi di “creazione di contenuti” (sì, suona strano dirlo in italiano, lo so): qui la parola scritta resiste, affiancando ancora immagini e video.