Nel romanzo La Madre di Maksim Gor’kij
 Russia, inizio Novecento. La prima fase del processo di industrializzazione iniziata alla fine dell’Ottocento ha portato alla creazione di primi distretti industriali e del proletariato urbano anche in terra russa. Il romanzo di Gor’kij, La madre, si apre con la descrizione a tinte fosche di questa realtà: un sobborgo tetro e fumoso, dove i giganteschi edifici della fabbrica si fanno ancora più cupi al suono della sirena, nell’andirivieni degli operai, con i loro visi anneriti e le loro espressioni cupe. Il racconto è introdotto dalla comparsa di Michail Vlasov, fabbro di mezza età che conduce una vita di stenti, persa nel solo lavoro alla fabbrica e nell’ubriachezza continua. Vlasov ha una famiglia: il figlio Pavel e la moglie Pelageja. La vita familiare è scandita dalla rabbia muta di Vlasov, marito e padre violento che per lunghi anni usa violenza sulla moglie, vittima rassegnata. Ma il ruolo di Michail giunge presto al termine. Ormai minato nel fisico e nel morale dalla vita alla fabbrica, Vlasov muore dopo poche pagine del romanzo. Continua a leggere “La Russia verso la rivoluzione”
Russia, inizio Novecento. La prima fase del processo di industrializzazione iniziata alla fine dell’Ottocento ha portato alla creazione di primi distretti industriali e del proletariato urbano anche in terra russa. Il romanzo di Gor’kij, La madre, si apre con la descrizione a tinte fosche di questa realtà: un sobborgo tetro e fumoso, dove i giganteschi edifici della fabbrica si fanno ancora più cupi al suono della sirena, nell’andirivieni degli operai, con i loro visi anneriti e le loro espressioni cupe. Il racconto è introdotto dalla comparsa di Michail Vlasov, fabbro di mezza età che conduce una vita di stenti, persa nel solo lavoro alla fabbrica e nell’ubriachezza continua. Vlasov ha una famiglia: il figlio Pavel e la moglie Pelageja. La vita familiare è scandita dalla rabbia muta di Vlasov, marito e padre violento che per lunghi anni usa violenza sulla moglie, vittima rassegnata. Ma il ruolo di Michail giunge presto al termine. Ormai minato nel fisico e nel morale dalla vita alla fabbrica, Vlasov muore dopo poche pagine del romanzo. Continua a leggere “La Russia verso la rivoluzione”
 Se siete stanchi di impegno, se ne avete abbastanza di sentire politici ripetere sempre le stesse cose e, ugualmente, non ne potete più di ascoltare la lamentela popolare col suo traboccare di luoghi comuni, fate un gesto di evasione, salvatevi. Isolatevi, egoisticamente, in un mondo piacevole, leggero. Plasmatelo a vostro uso e consumo, senza pensieri. Sedetevi in poltrona, sorseggiate un buon whisky invecchiato (o se non vi piace il genere, una tisana esotica o un tè), e leggetevi un libro. Oggi che l’invito alla lettura è diventato un’ennesima forma di impegno, e che questo “appello” qualche volta risulta un po’ antipatico (leggere fa bene, come mangiare frutta e verdura), leviamo subito di torno l’impegno. Leggetevi disimpegnati romanzi di genere, secondo la vostra indole. Divertitevi con la storia, la narrazione. Se vi va, seguite le mode del momento, gli autori da classifica.
Se siete stanchi di impegno, se ne avete abbastanza di sentire politici ripetere sempre le stesse cose e, ugualmente, non ne potete più di ascoltare la lamentela popolare col suo traboccare di luoghi comuni, fate un gesto di evasione, salvatevi. Isolatevi, egoisticamente, in un mondo piacevole, leggero. Plasmatelo a vostro uso e consumo, senza pensieri. Sedetevi in poltrona, sorseggiate un buon whisky invecchiato (o se non vi piace il genere, una tisana esotica o un tè), e leggetevi un libro. Oggi che l’invito alla lettura è diventato un’ennesima forma di impegno, e che questo “appello” qualche volta risulta un po’ antipatico (leggere fa bene, come mangiare frutta e verdura), leviamo subito di torno l’impegno. Leggetevi disimpegnati romanzi di genere, secondo la vostra indole. Divertitevi con la storia, la narrazione. Se vi va, seguite le mode del momento, gli autori da classifica.  L’era globale è una grande promessa. Due elementi concorrono ad oscurare le potenzialità di un mondo globale: gli attriti nel panorama geopolitico tra gli Stati Uniti, la Russia e la Cina (con un’Europa che sta a guardare), e una globalizzazione solo economica, mal gestita dalla politica e guidata da un iperliberismo senza regole. In queste pagine si presenta l’era globale sotto un’altra luce. Anche grazie ad esempi tratti dalla storia europea e asiatica, si mostra come il processo di incontro, assimilazione e rielaborazione di culture “diverse” sia un processo storico che genera incredibile vitalità creativa nelle civiltà umane, in tutte le epoche e in tutti i continenti. Questo processo, infatti, sta alla base di molte epoche storiche di splendore e fervore intellettuale. Partendo da queste considerazioni, l’autore propone il concetto di “cittadino globale” per indicare una condizione interiore e un percorso di formazione (anche scolastico) allo stesso tempo identitario e multiculturale, capace di creare una forma mentis e un tipo di cittadino nuovo, premessa per una società più creativa e un contesto internazionale più cooperativo e meno conflittuale.
L’era globale è una grande promessa. Due elementi concorrono ad oscurare le potenzialità di un mondo globale: gli attriti nel panorama geopolitico tra gli Stati Uniti, la Russia e la Cina (con un’Europa che sta a guardare), e una globalizzazione solo economica, mal gestita dalla politica e guidata da un iperliberismo senza regole. In queste pagine si presenta l’era globale sotto un’altra luce. Anche grazie ad esempi tratti dalla storia europea e asiatica, si mostra come il processo di incontro, assimilazione e rielaborazione di culture “diverse” sia un processo storico che genera incredibile vitalità creativa nelle civiltà umane, in tutte le epoche e in tutti i continenti. Questo processo, infatti, sta alla base di molte epoche storiche di splendore e fervore intellettuale. Partendo da queste considerazioni, l’autore propone il concetto di “cittadino globale” per indicare una condizione interiore e un percorso di formazione (anche scolastico) allo stesso tempo identitario e multiculturale, capace di creare una forma mentis e un tipo di cittadino nuovo, premessa per una società più creativa e un contesto internazionale più cooperativo e meno conflittuale. Orlando Figes è un noto russista inglese, docente all’università di Londra. Il suo voluminoso libro, Gli Europei. Tre vite cosmopolite e la costruzione della cultura europea nel XIX secolo, (Mondadori 2019) ha ambizioni più ampie che fuoriescono dal recinto degli studi slavi che gli è proprio. Partendo dalla biografia di un autore centrale della storia letteraria russa, Ivan Turgenev, e di Pauline e Louis Viardot, Figes racconta sullo sfondo biografico il processo di formazione di una cultura comune europea che proprio nei decenni centrali del XIX secolo stava emergendo in tutta la sua evidenza. L’intreccio tra le vicende biografiche dei personaggi storici ritratti rende la narrazione avvincente, e fornisce lo spunto per parlare di tali mutamenti sociali e culturali.
Orlando Figes è un noto russista inglese, docente all’università di Londra. Il suo voluminoso libro, Gli Europei. Tre vite cosmopolite e la costruzione della cultura europea nel XIX secolo, (Mondadori 2019) ha ambizioni più ampie che fuoriescono dal recinto degli studi slavi che gli è proprio. Partendo dalla biografia di un autore centrale della storia letteraria russa, Ivan Turgenev, e di Pauline e Louis Viardot, Figes racconta sullo sfondo biografico il processo di formazione di una cultura comune europea che proprio nei decenni centrali del XIX secolo stava emergendo in tutta la sua evidenza. L’intreccio tra le vicende biografiche dei personaggi storici ritratti rende la narrazione avvincente, e fornisce lo spunto per parlare di tali mutamenti sociali e culturali.  Insaziabilità, il romanzo del polacco Witkiewicz del 1930, è un’opera assurda e totalmente folle. E anche per questo è un capolavoro. Oltre cinquecento pagine di rimuginio interiore, in una prosa iper-barocca e serratissima, vivace, confondente, labirintica e alienante, dove la trama assume quasi un’importanza secondaria. La storia, infatti si riassume in poche righe. Il romanzo racconta la storia del giovane Genezyp Kapen, figlio di un ricco birraio, che finisce nell’esercito. Il contesto che fa da sfondo alla vicenda è abbastanza inquietante. Siamo in un momento indefinito del XX secolo, e il cinesi stanno conquistando militarmente il mondo ed esportando il comunismo. Grazie all’adozione dell’alfabeto (sic!), la loro civiltà ha avuto un’accelerazione improvvisa, sorpassando militarmente e tecnologicamente il resto del mondo. Loro missione è governare la “razza” bianca, ormai moralmente decaduta e incapace di governarsi autonomamente, ed estirpare l’individualismo, malattia dell’occidente; arrivati al loro obiettivo, infatti, imporrano l’ibridazione tra i “gialli” e i “bianchi” per creare una razza nuova e risollevare le sorti dell’umanità.
Insaziabilità, il romanzo del polacco Witkiewicz del 1930, è un’opera assurda e totalmente folle. E anche per questo è un capolavoro. Oltre cinquecento pagine di rimuginio interiore, in una prosa iper-barocca e serratissima, vivace, confondente, labirintica e alienante, dove la trama assume quasi un’importanza secondaria. La storia, infatti si riassume in poche righe. Il romanzo racconta la storia del giovane Genezyp Kapen, figlio di un ricco birraio, che finisce nell’esercito. Il contesto che fa da sfondo alla vicenda è abbastanza inquietante. Siamo in un momento indefinito del XX secolo, e il cinesi stanno conquistando militarmente il mondo ed esportando il comunismo. Grazie all’adozione dell’alfabeto (sic!), la loro civiltà ha avuto un’accelerazione improvvisa, sorpassando militarmente e tecnologicamente il resto del mondo. Loro missione è governare la “razza” bianca, ormai moralmente decaduta e incapace di governarsi autonomamente, ed estirpare l’individualismo, malattia dell’occidente; arrivati al loro obiettivo, infatti, imporrano l’ibridazione tra i “gialli” e i “bianchi” per creare una razza nuova e risollevare le sorti dell’umanità.  Giorgio Amitrano è un noto yamatologo, docente all’Orientale di Napoli. Il termine yamatologo forse è ormai desueto: designa uno studioso della cultura giapponese, in particolare della lingua e della letteratura. In questo suo Iro iro. Il Giappone tra pop e sublime, l’autore abbandona i panni dello studioso e si lascia andare un po’. Non un testo freddo, accademico, da specialista, ma un’incursione variopinta in vari ambiti della multiforme cultura nipponica. Quello di Amitrano è un vero, grande amore. Il lettore, al di là del contenuto, percepisce subito il tono incantato nel raccontarci del Giappone. Il libro è inframezzato da riflessioni con qualche nota biografica: da queste scopriamo che la passione per il Giappone iniziò negli anni universitari, che l’autore visse per alcuni anni a più riprese in varie città del paese, e che questa dimensione immaginativa non lo ha mai più lasciato da allora. Ma tale passione si era finora espressa nel linguaggio della didattica universitaria, degli articoli accademici.
Giorgio Amitrano è un noto yamatologo, docente all’Orientale di Napoli. Il termine yamatologo forse è ormai desueto: designa uno studioso della cultura giapponese, in particolare della lingua e della letteratura. In questo suo Iro iro. Il Giappone tra pop e sublime, l’autore abbandona i panni dello studioso e si lascia andare un po’. Non un testo freddo, accademico, da specialista, ma un’incursione variopinta in vari ambiti della multiforme cultura nipponica. Quello di Amitrano è un vero, grande amore. Il lettore, al di là del contenuto, percepisce subito il tono incantato nel raccontarci del Giappone. Il libro è inframezzato da riflessioni con qualche nota biografica: da queste scopriamo che la passione per il Giappone iniziò negli anni universitari, che l’autore visse per alcuni anni a più riprese in varie città del paese, e che questa dimensione immaginativa non lo ha mai più lasciato da allora. Ma tale passione si era finora espressa nel linguaggio della didattica universitaria, degli articoli accademici.  Dopo una notte tormentata e un’inquietante visione premonitrice, il trentenne Gingio viene visitato dal paludato e maturo professor Pimko. Constatata l’immaturità di Gingio, al puntiglioso professore pare inaccettabile lasciare Gingio nella sua immaturità, e ritiene suo dovere “rimpicciolirlo”, fargli cioè intraprendere un percorso adeguato di maturazione, e ricondurlo quindi a scuola. Da quel momento la vita del protagonista si fa assurda e grottesca. Gingio torna a scuola, in mezzo ai ragazzi, ma… nessuno si rende conto che si tratta di un uomo adulto e tutti lo trattano come un ragazzino. Questa l’idea di fondo su cui si sviluppa il romanzo Ferdydurke (titolo nonsense) di Witold Gombrowicz, autore polacco della metà del secolo scorso.
Dopo una notte tormentata e un’inquietante visione premonitrice, il trentenne Gingio viene visitato dal paludato e maturo professor Pimko. Constatata l’immaturità di Gingio, al puntiglioso professore pare inaccettabile lasciare Gingio nella sua immaturità, e ritiene suo dovere “rimpicciolirlo”, fargli cioè intraprendere un percorso adeguato di maturazione, e ricondurlo quindi a scuola. Da quel momento la vita del protagonista si fa assurda e grottesca. Gingio torna a scuola, in mezzo ai ragazzi, ma… nessuno si rende conto che si tratta di un uomo adulto e tutti lo trattano come un ragazzino. Questa l’idea di fondo su cui si sviluppa il romanzo Ferdydurke (titolo nonsense) di Witold Gombrowicz, autore polacco della metà del secolo scorso.  In un mondo dove la comunicazione è tanto pervasiva, siamo ancora capaci di conversare, di parlare tra di noi e di trarne reciproco vantaggio e piacere? Nell’osservarci da fuori, cosi intenti in dialoghi muti con gli schermi dei nostri strumenti tecnologici, nel dilagare delle parole che si sovrappongono nel vecchio ma ancora vitale mezzo televisivo e nella vita di tutti i giorni, sarebbe lecito dubitarne. Ma c’è stata un’epoca nella quale questa attitudine tipicamente umana veniva tenuta in gran conto e in cui conversazione e civiltà hanno largamente coinciso. Tra XVII e XVIII secolo l’Europa, prendendo a modello la cultura di corte del Rinascimento italiano, costruiva una società in cui la parola e il rituale dello stare insieme assumevano un valore centrale e fine a se stesso. E l’epoca dei salotti nobiliari, prima puramente frivoli, e via via luoghi di dibattito delle idee, luoghi dove pare abbiano persino visto la luce le idee illuministe.
In un mondo dove la comunicazione è tanto pervasiva, siamo ancora capaci di conversare, di parlare tra di noi e di trarne reciproco vantaggio e piacere? Nell’osservarci da fuori, cosi intenti in dialoghi muti con gli schermi dei nostri strumenti tecnologici, nel dilagare delle parole che si sovrappongono nel vecchio ma ancora vitale mezzo televisivo e nella vita di tutti i giorni, sarebbe lecito dubitarne. Ma c’è stata un’epoca nella quale questa attitudine tipicamente umana veniva tenuta in gran conto e in cui conversazione e civiltà hanno largamente coinciso. Tra XVII e XVIII secolo l’Europa, prendendo a modello la cultura di corte del Rinascimento italiano, costruiva una società in cui la parola e il rituale dello stare insieme assumevano un valore centrale e fine a se stesso. E l’epoca dei salotti nobiliari, prima puramente frivoli, e via via luoghi di dibattito delle idee, luoghi dove pare abbiano persino visto la luce le idee illuministe. 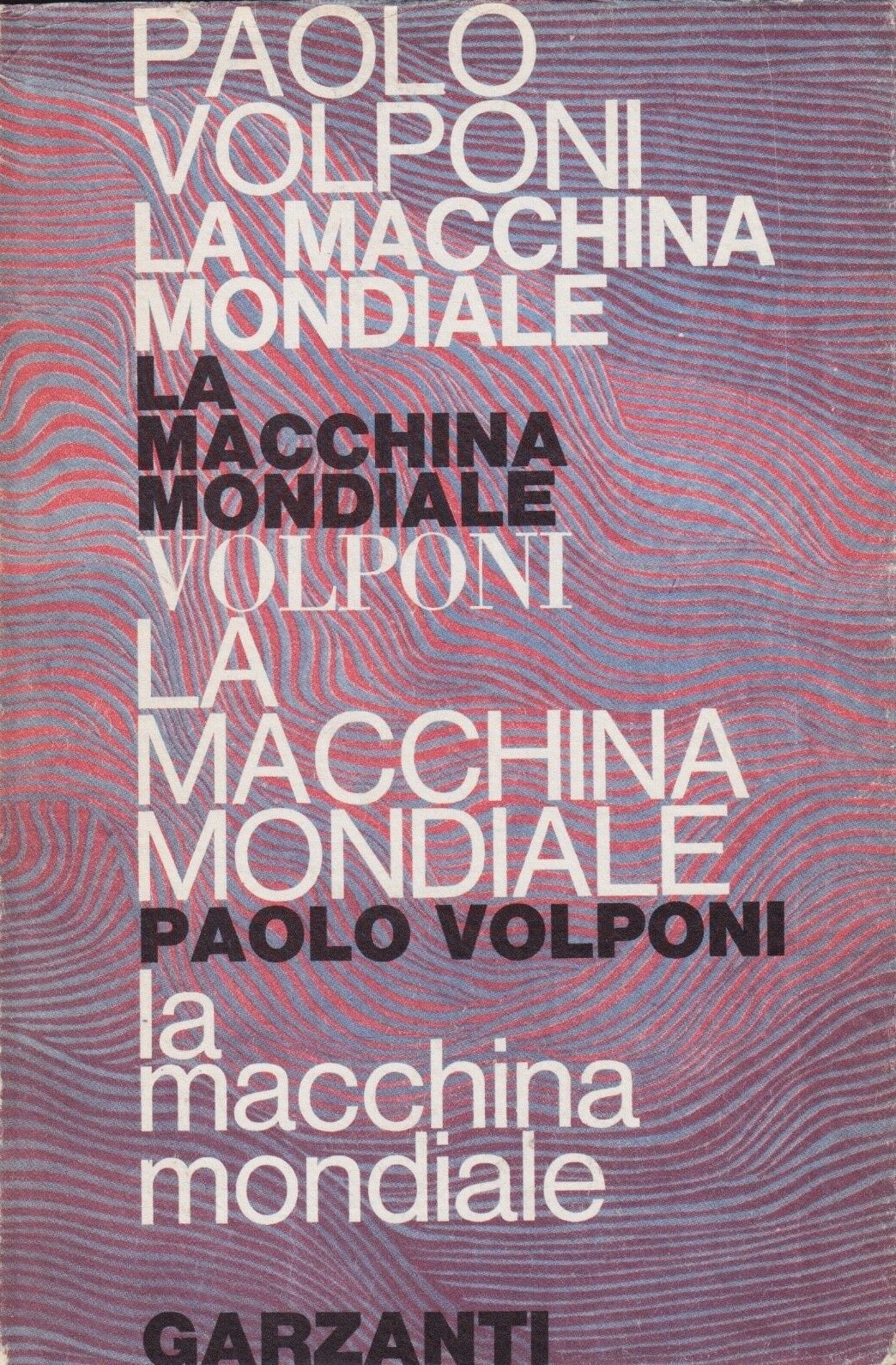 Nel 1965 il premio Strega, uno dei più prestigiosi premi letterari italiani, venne assegnato a un romanzo breve di un autore che oggi è perlopiù caduto nel dimenticatoio. Triste destino condiviso da molti importanti autori della nostra letteratura nel secondo dopoguerra. Il romanzo sul quale spenderemo qualche parola è La macchina mondiale di Paolo Volponi. Nativo della piccola città di Urbino, Volponi era stato una figura di letterato noto tra gli anni Cinquanta e Sessanta, in particolare per il suo ruolo di dirigente alla Olivetti, ruolo che gli era stato assegnato proprio per portare avanti l’utopia olivettiana di industria umana e culturale. Nell’opera non vastissima di Volponi La macchina mondiale è certamente il libro più importante, e di questa utopia serba una forte traccia.
Nel 1965 il premio Strega, uno dei più prestigiosi premi letterari italiani, venne assegnato a un romanzo breve di un autore che oggi è perlopiù caduto nel dimenticatoio. Triste destino condiviso da molti importanti autori della nostra letteratura nel secondo dopoguerra. Il romanzo sul quale spenderemo qualche parola è La macchina mondiale di Paolo Volponi. Nativo della piccola città di Urbino, Volponi era stato una figura di letterato noto tra gli anni Cinquanta e Sessanta, in particolare per il suo ruolo di dirigente alla Olivetti, ruolo che gli era stato assegnato proprio per portare avanti l’utopia olivettiana di industria umana e culturale. Nell’opera non vastissima di Volponi La macchina mondiale è certamente il libro più importante, e di questa utopia serba una forte traccia.  Adolf Dygasiński (1839-1902), scrittore polacco, in La festa della vita (Gody życia, 1900) descrive la vita di un uccellino, un piccolo e comune scricciolo. Il piccolo volatile vive in povertà, osservando gli uccelli migratori nel loro cosmopolitismo alla ricerca di un’abbondanza sempre a portata di mano. Ma lo scricciolo ha deciso di vivere in prima persona tutte le stagioni, sopportando lo squallore e la fame dell’inverno per poi attendere la ricchezza ritrovata della primavera. Nonostante questo alternarsi di fortune, l’uccellino non è mai triste, perché il tempo ciclico gli ha dimostrato che sofferenze e miserie sono mali passeggeri, mentre solo la gioia per la vita può essere eterna, se sappiamo come affrontarla.
Adolf Dygasiński (1839-1902), scrittore polacco, in La festa della vita (Gody życia, 1900) descrive la vita di un uccellino, un piccolo e comune scricciolo. Il piccolo volatile vive in povertà, osservando gli uccelli migratori nel loro cosmopolitismo alla ricerca di un’abbondanza sempre a portata di mano. Ma lo scricciolo ha deciso di vivere in prima persona tutte le stagioni, sopportando lo squallore e la fame dell’inverno per poi attendere la ricchezza ritrovata della primavera. Nonostante questo alternarsi di fortune, l’uccellino non è mai triste, perché il tempo ciclico gli ha dimostrato che sofferenze e miserie sono mali passeggeri, mentre solo la gioia per la vita può essere eterna, se sappiamo come affrontarla. 

 ltre cinquecento pagine fitte di storia del pensiero, ma anche di minuziosi analisi antropologiche sul sostrato mitico-religioso autoctono del Giappone. È il contenuto del libro di Massimo Raveri, Il pensiero giapponese classico (Einaudi, 2014). Massimo Raveri è uno dei più noti specialisti di spiritualità e pensiero orientale, ed è docente di Religioni e Filosofie dell’Asia Orientale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il suo testo è un riferimento per il settore, e tra le pagine del libro si trova qualcosa di più della sola storia del pensiero. Raveri ci conduce in un viaggio in cui pensare, credere e vivere sono perfettamente integrati, visto che i confini tra queste sfere dell’esistenza in Asia sono certamente meno sfumati che in Occidente. Almeno in epoche premoderne.
ltre cinquecento pagine fitte di storia del pensiero, ma anche di minuziosi analisi antropologiche sul sostrato mitico-religioso autoctono del Giappone. È il contenuto del libro di Massimo Raveri, Il pensiero giapponese classico (Einaudi, 2014). Massimo Raveri è uno dei più noti specialisti di spiritualità e pensiero orientale, ed è docente di Religioni e Filosofie dell’Asia Orientale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il suo testo è un riferimento per il settore, e tra le pagine del libro si trova qualcosa di più della sola storia del pensiero. Raveri ci conduce in un viaggio in cui pensare, credere e vivere sono perfettamente integrati, visto che i confini tra queste sfere dell’esistenza in Asia sono certamente meno sfumati che in Occidente. Almeno in epoche premoderne. 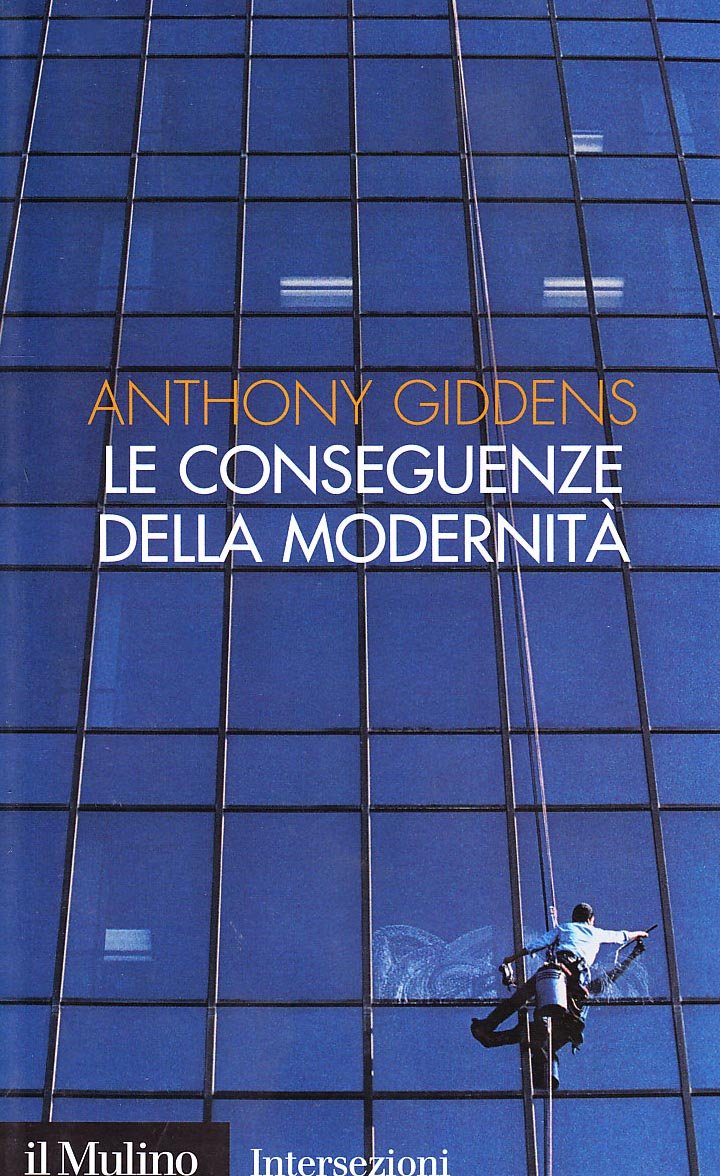 In un breve saggio intitolato Le conseguenze della modernità uscito all’inizio degli anni Novanta, il sociologo Anthony Giddens tirava le somme della sua ricerca, cercando di capire quale fossero le caratteristiche peculiari della nostra epoca. Sono trascorsi trent’anni dalla pubblicazione di quello scritto, ma le idee di Giddens conservano una loro utilità interpretativa. Giddens proponeva di sostituire il concetto di postmoderno con quello di modernità radicale. Il termine “postmoderno” verso la fine degli anni Settanta e per gran parte degli anni Ottanta del XX secolo aveva avuto ampio spazio nella pubblicistica e nel costume, in arte e in letteratura. Nel dibattito filosofico il termine si era imposto grazie al breve libro del filosofo Jean-Francois Lyotard, La condizione postmoderna. Uscito nel 1979, il libro di Lyotard faceva il punto della situazione di idee che erano nell’aria da tempo (
In un breve saggio intitolato Le conseguenze della modernità uscito all’inizio degli anni Novanta, il sociologo Anthony Giddens tirava le somme della sua ricerca, cercando di capire quale fossero le caratteristiche peculiari della nostra epoca. Sono trascorsi trent’anni dalla pubblicazione di quello scritto, ma le idee di Giddens conservano una loro utilità interpretativa. Giddens proponeva di sostituire il concetto di postmoderno con quello di modernità radicale. Il termine “postmoderno” verso la fine degli anni Settanta e per gran parte degli anni Ottanta del XX secolo aveva avuto ampio spazio nella pubblicistica e nel costume, in arte e in letteratura. Nel dibattito filosofico il termine si era imposto grazie al breve libro del filosofo Jean-Francois Lyotard, La condizione postmoderna. Uscito nel 1979, il libro di Lyotard faceva il punto della situazione di idee che erano nell’aria da tempo (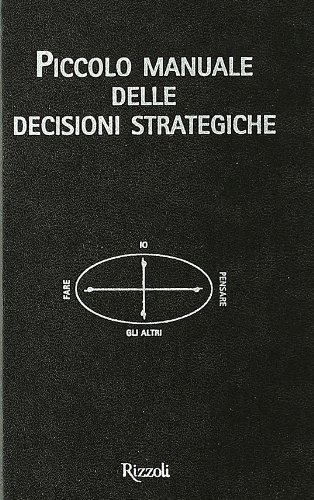 Un piccolo libro, con la copertina rigida, nera, in finta pelle. Il titolo è impresso in caratteri argentati. Sembra una Bibbia, ma è il Piccolo manuale delle decisioni strategiche, di Mikael Krogerus e Roman Tsch
Un piccolo libro, con la copertina rigida, nera, in finta pelle. Il titolo è impresso in caratteri argentati. Sembra una Bibbia, ma è il Piccolo manuale delle decisioni strategiche, di Mikael Krogerus e Roman Tsch Nel tempo delle ossessioni per il recupero di “radici” culturali (inventate), se ti imbatti in artisti come Namewee puoi perdere il senso dell’orientamento. Giovane artista malese di grande fama nel Sud-est asiatico, canta in cinese, sua lingua madre insieme al malese, e in varie altre lingue. Scrive canzoni dal gran piglio ironico (qualche volta vicino ai nostri Elio e le storie tese), e si diverte a prendere in giro in modo affettuoso, cambiando lingua all’occorrenza, i vari popoli di quell’area di mondo. Ridi e scherza, macina milioni di visualizzazioni su Youtube. Finge spensieratezza, ma si coglie, qua e là, una sua visione politica che… dovrete scoprire da soli.
Nel tempo delle ossessioni per il recupero di “radici” culturali (inventate), se ti imbatti in artisti come Namewee puoi perdere il senso dell’orientamento. Giovane artista malese di grande fama nel Sud-est asiatico, canta in cinese, sua lingua madre insieme al malese, e in varie altre lingue. Scrive canzoni dal gran piglio ironico (qualche volta vicino ai nostri Elio e le storie tese), e si diverte a prendere in giro in modo affettuoso, cambiando lingua all’occorrenza, i vari popoli di quell’area di mondo. Ridi e scherza, macina milioni di visualizzazioni su Youtube. Finge spensieratezza, ma si coglie, qua e là, una sua visione politica che… dovrete scoprire da soli.  C’è una definizione possibile dell’opera di Nikolaj Gogol’, scrittore russo (nato nell’odierna Ucraina) e ricompreso nel canone dei “classici”: Gogol’ è un prontuario di prototipi di personaggi della letteratura russa e universale delle epoche successive. Mi spiego meglio. Leggendo le sue opere, dai racconti, al più noto romanzo Le anime morte, e se si conoscono per sommi capi le linee di sviluppo principali della letteratura successiva, del grande romanzo ottocentesco e novecentesco europeo, si incontrano, appena accennati o già riconoscibili, temi, atmosfere, personaggi che poi la stessa letteratura europea e mondiale farà propri.
C’è una definizione possibile dell’opera di Nikolaj Gogol’, scrittore russo (nato nell’odierna Ucraina) e ricompreso nel canone dei “classici”: Gogol’ è un prontuario di prototipi di personaggi della letteratura russa e universale delle epoche successive. Mi spiego meglio. Leggendo le sue opere, dai racconti, al più noto romanzo Le anime morte, e se si conoscono per sommi capi le linee di sviluppo principali della letteratura successiva, del grande romanzo ottocentesco e novecentesco europeo, si incontrano, appena accennati o già riconoscibili, temi, atmosfere, personaggi che poi la stessa letteratura europea e mondiale farà propri.  Metropoli cosmopolita, cultura cosmopolita, società cosmopolita. Queste espressioni si sono fossilizzate nel gergo giornalistico e, come tutte le espressioni abusate, sono diventate troppo vaghe per avere un significato. Ma il cosmopolitismo è faccenda serie: è un concetto filosofico e politico, sociale e antropologico insieme. Contiene in sé secoli di idealismo e di sogni che dipingono società integrate nella diversità sotto l’unico denominatore comune dell’umanità. Nel procurarmi materiale per un libro, ho dovuto documentarmi con un certo scrupolo, cercando di capire il cosmopolitismo declinato nella nostra epoca. Da qui deriva questa mia breve nota di lettura sul libro di Angela Taraborelli, Il cosmopolitismo contemporaneo (Ed. Laterza, 2011).
Metropoli cosmopolita, cultura cosmopolita, società cosmopolita. Queste espressioni si sono fossilizzate nel gergo giornalistico e, come tutte le espressioni abusate, sono diventate troppo vaghe per avere un significato. Ma il cosmopolitismo è faccenda serie: è un concetto filosofico e politico, sociale e antropologico insieme. Contiene in sé secoli di idealismo e di sogni che dipingono società integrate nella diversità sotto l’unico denominatore comune dell’umanità. Nel procurarmi materiale per un libro, ho dovuto documentarmi con un certo scrupolo, cercando di capire il cosmopolitismo declinato nella nostra epoca. Da qui deriva questa mia breve nota di lettura sul libro di Angela Taraborelli, Il cosmopolitismo contemporaneo (Ed. Laterza, 2011).  Benny Lewis è un noto poliglotta irlandese che ha riscosso un certo successo mediatico sul web, anche grazie al suo ruolo di testimonial per una piattaforma on-line (a pagamento) per imparare le lingue da autodidatta. Ho sempre avuto una certa perplessità per i poliglotti dell’epoca del web, quanto stima per gli eruditi del passato, traduttori, lettori di opere letterarie e scientifiche, unico vero modo per imparare in profondità un idioma straniero oltre la soglia dell’uso colloquiale (come il “santo” protettore dei poliglotti, il leggendario Cardinale Gaspare Mezzofanti). Ascoltando coloro che dicono di conoscere molte lingue sul web, non di rado mi sono imbattuto in una pronuncia sommaria, in frasi standard imparate a memoria, giusto per realizzare un video “poliglotta” acchiappa like su Youtube. Mi sono accorto di questa finzione mediatica solo per quelle (poche) lingue che mastico un poco, e che esercito con gran fatica e dedizione (direi amore, nel senso sentimentale del termine); la perplessità di ridurre la conoscenza di una lingua a qualche frase imparata a memoria, come dicevo, mi ha sempre lasciato perplesso.
Benny Lewis è un noto poliglotta irlandese che ha riscosso un certo successo mediatico sul web, anche grazie al suo ruolo di testimonial per una piattaforma on-line (a pagamento) per imparare le lingue da autodidatta. Ho sempre avuto una certa perplessità per i poliglotti dell’epoca del web, quanto stima per gli eruditi del passato, traduttori, lettori di opere letterarie e scientifiche, unico vero modo per imparare in profondità un idioma straniero oltre la soglia dell’uso colloquiale (come il “santo” protettore dei poliglotti, il leggendario Cardinale Gaspare Mezzofanti). Ascoltando coloro che dicono di conoscere molte lingue sul web, non di rado mi sono imbattuto in una pronuncia sommaria, in frasi standard imparate a memoria, giusto per realizzare un video “poliglotta” acchiappa like su Youtube. Mi sono accorto di questa finzione mediatica solo per quelle (poche) lingue che mastico un poco, e che esercito con gran fatica e dedizione (direi amore, nel senso sentimentale del termine); la perplessità di ridurre la conoscenza di una lingua a qualche frase imparata a memoria, come dicevo, mi ha sempre lasciato perplesso.  Michail Lermontov è un poeta e scrittore russo che pare egli stesso personaggio letterario. Anima tormentata, tipico rappresentante di quello che tra le aule scolastiche avete sentito definire come “titanismo romantico”, Lermontov muore giovane in seguito ad un duello, a soli ventisette anni. La giovane età lo pone in un ruolo problematico nel contesto letterario russo. Da un lato, il breve tratto di tempo che ha costituito la sua vita non gli ha permesso di raggiungere a pieno la sua maturità artistica. Dall’altro Lermontov ha lasciato versi e opere in prosa che ci paiono perfettamente compiute e che collocano l’autore in un panorama di respiro europeo.
Michail Lermontov è un poeta e scrittore russo che pare egli stesso personaggio letterario. Anima tormentata, tipico rappresentante di quello che tra le aule scolastiche avete sentito definire come “titanismo romantico”, Lermontov muore giovane in seguito ad un duello, a soli ventisette anni. La giovane età lo pone in un ruolo problematico nel contesto letterario russo. Da un lato, il breve tratto di tempo che ha costituito la sua vita non gli ha permesso di raggiungere a pieno la sua maturità artistica. Dall’altro Lermontov ha lasciato versi e opere in prosa che ci paiono perfettamente compiute e che collocano l’autore in un panorama di respiro europeo.